 In principio era il Verbo…
In principio era il Verbo…
Il linguaggio, a partire dai suoi elementi primi e dalla sua funzione ‘base’ di nomenclatura di oggetti e parti della realtà presume sempre una convergenza intersogettiva e un doxa sociale e culturale (un’opinione condivisa, un accordo collettivo, una legge implicita ed esplicita). Il linguaggio serve per farsi capire dall’altro, ma anche per capire se stessi e capire l’altro. Tutto ciò potrebbe avere un sua dimensione psichica nell’inconscio collettivo di Jung, ma nell’affermare questa ipotesi o correlazione compiamo un atto interpretativo basato su ipotesi e interpretazioni strutturate entro una certa teoria della psiche.
L’inconscio collettivo di Jung o altrimenti il suo concetto di ‘psiche oggettiva’ (conscia e inconscia) sono costrutti concettuali sostenuti da una semiotica del mito, delle leggende e dei fondamenti archetipici. Si tratta di operatori psicoculturali di senso, quindi di sistemi di significazione e processi di comunicazione che sostanziano le coordinate esistenziali attraverso le quali ciascuno dovrebbe individuare il suo ‘principio di individuazione’ (Jung), il suo ‘codice dell’anima’ (Hillman), oppure la sua interpretazione idiopatica, soggettiva, unica e irripetibile del suo essere nel mondo, in quanto ‘essere per la morte’ (Heidegger), perché solo con la morte diventa essere compiuto in quanto ‘essere infinito, ma non eterno’, assoluto, ma non totalizzato. Ecco allora che una ‘semiotica dell’essere’, nella sua sovrabbondante presunzione, ci porta ad interrogarci sul senso di questo verbo essere. Nonostante vogliamo solo porgere una modesta riflessione, siamo consapevoli di come ciò potrebbe provocare un sorriso di derisione, di compassione o di fastidio sulle labbra di tutti i filosofi, giacché l’essere è un problema primo, della logica, dell’etica, dell’estetica, della metafisica o della politica, ma è anche un problema ermetico, psicospirituale, antropologico e linguistico. Immenso è il problema dell’essere, immense sono le ispirazioni che esso ci dona.
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
(Giovanni, Vangelo)
Nella sentenza “In principio era il Verbo”, il verbo appare nel tempo imperfetto.
Il verbo greco è en, che significa “era”. In realtà en è l’imperfetto del verbo greco eimi, ossia: essere. L’Apostolo Giovanni ci dice quindi che “in principio”, ossia prima della creazione del mondo, prima di ogni cosa, da sempre, esisteva il Logos, che in italiano viene tradotto “la Parola” o “il Verbo”. Pertanto si potrebbe concludere che Giovanni volesse indicare che il Verbo esisteva prima che ci fosse qualsiasi inizio, prima di ogni cosa. Il Verbo era pertanto pre-esistente ad ogni cosa. Era la Causa Prima.
Ciò vuole dire che Il Verbo è la manifestazione autoriflessiva di Dio, gli dà coscienza di sé e presso di sé, quindi anche oltre sé e oltre il mondo. Dio ha coscienza di Sé dal momento non solo che è, ma anche che è stato e che sarà, secondo un’eternità che può essere esperita solo attraverso il ‘Verbo’. Ma nella misura in cui il Verbo non è solo Logos, ossia parola, esso è propriamente il verbo cioè quello strumento linguistico che designa un fare, un agire, o appunto un ‘essere. Dio crea la sua creazione con il verbo: «Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu.»
In molti miti e pensieri magico-religiosi la deità crea attraverso sentenze e ordini che ordinano il mondo, e questo attraverso parole e verbi, predicati di senso. Il dio biblico in quest’attività di nominazione coinvolge anche gli umani, ma solo quando gli umani avranno acquisito il verbo potranno essere semidivini.
«Il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all’uomo [Adamo] per vedere come li avrebbe chiamati, e perché ogni essere vivente portasse il nome che l’uomo gli avrebbe dato. L’uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi…»
Ma al Dio/Verbo non basta conferire agli uomini la capacità e la responsabilità della nominazione, per cui solo per Adamo ed Eva egli dà il nome, lasciando che l’onomastica dei successori venga scelta dai genitori, o dal padre e ‘nel nome del Padre’. Seppure vi è un insistere sulla sacralità del nome, sull’innominabilità e sul fatto di non ‘nominare invano’, cioè di togliere a Dio così come a ogni nominato/battezzato il sacro valore del suo essere, occorre che al nome venga aggiunto il Verbo, il Verbo di Dio, che è appunto l’Essere supremo tra gli esseri.
L’acquisizione di essere un soggetto, quindi di poter avere coscienza dell’Io, secondo Lacan nasce dalla fase dello specchio, quando l’infante dinnanzi allo specchio, tra le braccia della madre si riconosce finalmente per la prima volta come da essa differenziato. Ma la nominazione attraverso il linguaggio di questo differenziale consistente nella soggettività viene investita da un nome, avviando nell’infante la relazione tra il suo essere soggetto e un segno, ossia un nome proprio. Il riconoscimento della paternità non potendo contare su prove certe, dipende esclusivamente dal suo nome, diventando quindi il primo significante e depositario del linguaggio. Mentre la madre è tale attraverso la legge di natura, il padre ha bisogno di una legge di cultura, la quale ha il suo ‘momento originario’ nella legittimazione del ‘nome padre’ sotto l’ordine del linguaggio.
Ecco allora che si ha un’esperienza di prima identità quando nel comprendere di essere stati associati, per così dire a un significante si dovrà constatare la differenza e la correlazione tra questo e il suo significato. Tale significato sarebbe l’Io, o comunque l’essere che sono Io. Questo passaggio è importante perché dal momento che c’è un nome c’è anche un verbo e questo verbo è l’essere. Nasce con l’uomo la domanda chi sono? Ecco che la risposta può ricercarsi in un vissuto coscienziale del quotidiano, identificandosi e i differenziandosi rispetto ai genitori, gli altri e le cose del mondo. Ma nel dirsi e farsi soggetto compare anche una coscienza estesa che a differenti livelli di complessità e profondità trasporta in un paradigma di senso più vasto, di ordine ideale, metafisico o trascendente, dato che l’essere mi fa sentire di essere non solo nella mia manifestazione esterna, ma anche nelle mie manifestazioni interne – oppure può ricercarsi su un piano sintagmatico, cioè della differenza che l’io si ritaglia nella sua unicità rispetto agli altri.
 Il nome e l’identità
Il nome e l’identità
Il bambino che acquisisce il senso e la funzione del suo nome in una prima fase può rispondere alla domanda ‘chi sei’ solo in senso intensionale: sono Giovanni” e quindi non sono un altro, e anche qualora ci fosse un altro Giovanni io no sarei quello lì. È stato Cicerone a introdurre il concetto e il nome dies onomastica per riferirsi alla celebrazione del nome. Poi i cattolici considerarono che ciascuno avesse un suo santo protettore e quindi la celebrazione del suo onomastico. Il nome è il segno principe dell’identità. Siamo segnati dal nostro nome, al punto da farci dimenticare che noi e gli altri non siamo nomi. Siamo qualcuno e insieme nessuno dal momento che dobbiamo avere un nome perché questa è la legge a cui nessuno può sfuggire, se non per mettersi in salvo, come reo o come fantasma.
Risuona miticamente ambivalente la risposta che diede Ulisse quando Polifemo gli chiese “Chi sei?”: “Nessuno”. Quel ‘nessuno’ doveva dunque essere un nome con la N maiuscola, altrimenti non poteva trattarsi di un ‘essere’, ma di un ‘non essere’. Insomma il nome risulta necessario rispetto all’essere, ciò non di meno il bambino costruisce la sua identità come personalità che si manifesta in un mondo esterno, ma che si fonda su un mondo interno che tuttavia viene dato per scontato. Intendo dire che il bambino si comporta in modo assai dipendente dal suo inconscio, o comunque da intenzioni e motivazioni dipendenti dal suo mondo interno e quindi incomincia capire un po’ alla volta che egli non è solo quel nome, quanto piuttosto un interprete di quel nome attraverso una sua propia esperienza di sé e del mondo. Questo processo di identizzazione nome-differenza-personalità da quindi avvio ad un’interpretazione analoga del nome degli altri, dietro quei nomi ci sarà un altro avente una sua propria natura, ovvero un suo proprio esserci. Ma secondo una concezione evoluzionistico cognitiva il bambino ha una visione interpretativa degli altri, dei coetanei, secondo logiche goffe ma possibili basate sulla cosiddetta ‘teoria della mente’; vale a dire che il bambino pensa che gli altri pensino come lui. Quindi il bambino considera che rispetto alla presa di coscienza identitaria della relazione tra essere e nome, gli altri siano al suo stesso livello.

Il nome è la legittimazione ad essere se stessi nel tempo e nello spazio della vita e oltre la vita, dalla culla alla lapide. Il nome perciò è sacro. Ogni forma di follia, è una dissacrazione del senso del nome, per se stessi e per la collettività. Che si tratti della follia di una mente saturnina e sclerotizzata che si intestardisce o che scompare, piuttosto di quella del puer che urla e che si autodistrugge pur di avere di più, o la follia che gioca alle false identità, o quella delle passioni mortifere, o quella che pretende di sopraffare gli altri secondo varie e ciniche psicopatie. In ogni caso di follia, o di abnormità, disfunzione si tratta pur sempre di perdita del significato identitario e sacro del proprio nome. Per quanto so come mi chiamo, non so più chi sono, o credo di essere un altro, o di dover essere un altro, oppure vado delirando ora con un nome ora con un altro. Eppure ciascuno per dare senso al suo essere deve avere in qualche modo avuto esperienza del mondo infero e della follia, perché senza il negativo l’essere è solo una parte, quindi non può essere. Nasce il problema di chissà ci si crede di essere, o di chi per forza si dovrebbe essere: il tormento di un nome senza identità!
Ciascuno dunque ha bisogno di dare senso al proprio nome, affinché l’essere non diventi identità negata, puro nominalismo, egoistico flatus vocis che si perde nei flutti e nei vortici del tempo senza senso. Ciascuno per dare senso al suo nome deve imparare a dare senso al nome dell’altro, a rispettare l’altro nel suo nome.
 Il nome umano degli animali e viceversa
Il nome umano degli animali e viceversa
Nel mondo degli animali superiori, più o meno addomesticabili, noi osserviamo come l’animale diventi per così dire sensibile al fatto di essere chiamato con un nome. In termini comportamentistici, di una psicologia skinneriana S.R (stimolo risposta), il nome come segno di una individualità percepita non implica l’interrogarsi su una identità profonda, ovvero sull’essere nella sua soggettività e personalità come sopra riferito. Qui l’animale che si chiama ad esempio ‘Birillo’ se è un cane o un gatto o un cavallo si abitua ad associare il suono del suo nome a se stesso, in quanto soggetto avente ruoli e funzioni, soprattutto nei confronti dei suoi padroni. Da come gli umani pronunciano il suo nome intuisce se è a loro gradito o è sgradito. A volte, o a seconda dell’addestramento S/R ricevuto, l’animale risponde associando il sui nome a un qualche ordine, o un divieto, ma a volte fa finta di non capire o non capisce. In qualche modo però il cane, in particolare, sembra dotato una qualche conoscenza circa la personalità del suo padrone, differenziandola in modo minimale, ma significativo dalla personalità degli umani in generale. In tal senso a un qualche livello, come dimostra la zoosemiotica, gli animali sono dotati di linguaggio, sufficiente a riprodurre schemi di azione e reazione funzionali ed efficienti nella relazione uomo-animale-ambiente. Tuttavia questi animali non hanno concezione del ‘Verbo, come qualità capace di designare il tempo e lo spazio, cioè quelle categorie kantiane che ci consentono di riconoscere l’esistenza degli oggetti in uno spazio-tempo. In particolare il verbo nelle sue coniugazioni designa il tempo, passato, presente e futuro, oppure l’imperfetto e il trapassato. Ogni lingua ha una qualche sua particolare caratteristica nella declinazione del tempo, dal momento che ogni cultura declina il senso dell’essere con una sua propria visione ontologica, logica, grammaticale, semiotica e psicologica. L’essere è universale, ma è anche relativo.
Il processo identitario umano evolve attraverso la declinazione del verbo essere, secondo il suo innatismo e la sua cultura d’appartenenza, che si chiede a ciascuno, con maggiore o minore forza e in determinati momenti della vita: chi sono, cosa sarò nel futuro e quando non ci sarò, cosa ero o cosa sono stato prima di esserci. L’essere non fa solo una ricognizione attuale di cosa sia in senso sincronico, ma si interpreta e si progetta anche in senso genetico, quindi diacronico, oltre i limiti del tempo che gli è dato. Il nome degli umani è un modo di umanizzare gli animali, di conferire loro un essere. Ma gli animali sono esseri senza nome, lo accettano solo per permetterci di avere un accesso a loro, ma il problema umano inizia quando non ci ricordiamo di essere animali, e nello stesso tempo non si è neppure umani. Il nome diventa allora solo una maschera umanizzante, dietro al quale non c’è nessuno, oppure uno senza essere, un disumano che ha perso l’essere e che dovrebbe fare qualcosa per ritrovarlo, magari trovandolo negli animali. Un tempo era l’animale che conferiva il nome e il totem sacro agli umani, al loro spirito guida. Il nome sciamanico dell’animale sacro, diventa luce per affrontare il buio.
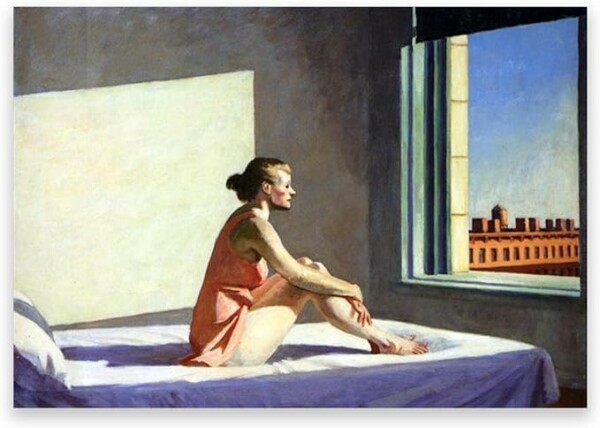 Essere al mondo e Psicoterapia
Essere al mondo e Psicoterapia
Secondo Jasper la comprensione dell’Essere nel mondo del paziente deve essere riferita alla sua condizione attuale e a quella genetica, intesa come interrelazioni storica tra passato e futuro, sul piano della sua vita relazionale primari, parentale e sociale, ma anche sul suo essere in un tempo e in una situazione storica. Ma il tempo presuppone quindi un essere in divenire, un’essenza metamorfica che in termini parmenidei si vorrebbe sempre immutabile e identica a se stessa, mentre in termini eraclitei implica un movimentarsi, attraverso frecce temporali che nel loro presentificarsi investe il passato e il futuro, Nella psicopatologi fenomenologica di Jaspers la malinconia consiste in una colonizzazione che il passato compie sul presente e sul futuro e che determina quindi l’impossibilità di esperire l’attualità e costringerà a considerare ogni il futuro come qualcosa che diventerà passato e che quindi non evolverà, e anzi involvere. Il futuro che diventerà passato, si presentifica alla coscienza come il ‘tempo della morte’. E’ una morte che però non consente di ‘essere per la morte’, nel senso di individuarsi nel tempo e nello spazio non più come sub-jectum, ma anche come pro-gectum, in quanto è una morte permanente nella vita, che nientifica il presente e il futuro con la permanenza stagnate e mortifera del passato. Un trauma, quindi, di qualunque natura impedisce alla verbalizzazione del presente e del futuro di avere un senso che non sia adombrato o ottenebrato dal passato. L’essere si fa non essere, nelle sue dolorose insufficienze e incongruenze… nella sua insostonibile leggerezza dell’essere (Kundera).
Tutti i verbi sono in se stessi indici di movimento in quanto attraverso le declinazioni transitano da linee temporali, ma ci sono molti verbi che designano movimenti di corpi e di oggetti, come correre, navigare, salire, rotolare. I predicati io sono, o sono stato, o sarò preludono comunque alla domanda dove? La Da-sein vuole appunto dare all’essere una collocazione situazionale in uno spazio-tempo, essa ci fa considerare l’oggettività che l’essere è solo in quanto esistente ed è pertanto collocato in uno spazio-tempo, che però non è quello kantiano degli a-priori categoriali, bensì è quello dell’essere nel mondo nel suo divenire storico e nella sua condizione situazionata. Essere qui, adesso, quindi esser-ci nello spazio e nel tempo, come ha espresso Heidegher, un ‘esserci’ che non è statico, immoto, inerte, ma è esserci per qualcosa, per una missione, un senso, un senso ultimo, un esser-ci impresso dalla propria individuazione, come diceva Jung, o dal proprio Daimon, come ha espresso Hillman, nel suo Codice dell’Anima. Ciascuno in suo nome esprime il suo esser-ci verso qualcosa, nell’Universo. Una psicoterapia del profondo è il viatico per compiere il proprio autentico viaggio nell’essere al mondo, un viatico attraverso il verbo di umanità, umiltà, coraggio e amore.

Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.